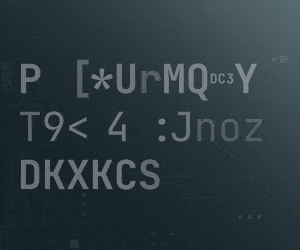Quo Vadis? Nell’industria che si interroga sulla via da prendere si coglie un senso di incertezza e preoccupazione su dove stanno andando le cose. Questo è il quadro mostrato dall’autorevole Financial Times: «Negli ultimi decenni, l’Occidente si è allontanato da una cultura del progresso verso una cultura basata sulla cautela, sulla preoccupazione e sull’avversione al rischio. Le previsioni sulla futura crescita economica sono diventate significativamente più cupe nel XXI secolo. I giovani adulti hanno meno fiducia nella mobilità ascendente. I combustibili fossili restano le fonti primarie di approvvigionamento energetico».
La via dell’Umanesimo Economico…
Viviamo in un’epoca in cui i problemi sono ostici ed è ampia la varietà delle soluzioni proposte. Basti pensare alle tante scuole economiche, ciascuna pretendendo di essere portatrice di verità. Ma questa ha tante facce, ciascuna rilevando un altro aspetto della realtà. Nel campo dell’innovazione, un esempio per tutti: i pareri sull’intelligenza artificiale attraversano un vasto arco i cui estremi sono “si tratta di una bolla speculativa al pari di quella sui prezzi dei bulbi di tulipano scoppiata nell’economia olandese del Seicento” ed “è paragonabile alla forza d’urto del motore a combustione che innescò la rivoluzione industriale”.
Imboccheremo la via il cui nome è Umanesimo Economico? È questa una filosofia sociale che mette al centro l’essere umano le cui motivazioni escono dal recinto dell’egoismo volto al perseguimento dell’interesse puramente personale. Il successo non è circoscritto ai risultati mostrati da metriche centrate sulla massimizzazione della produzione e del profitto. L’attività economica è di successo se sana. Il suo stato di salute dipende dall’etica, dai valori sociali, dalla prosperità condivisa, dalla sostenibilità ambientale, e da una vita lavorativa il cui significato vada ben oltre il benessere materiale per includere la considerazione del ben-essere fisico, mentale, emozionale e relazionale.
Messa di fronte all’Umanesimo Economico, l’industria dovrà dotarsi della forza culturale che bilancia crescita, efficienza e rendimenti degli azionisti con il ben-essere dei lavoratori e l’impatto ambientale.
Il futuro del lavoro

Il futuro sarà tracciato dalle tendenze e previsioni, rese più accurate dall’intelligenza artificiale? Oppure un futuro deliberatamente costruito da noi? Tendenze e previsioni sono briciole raccolte dai tavoli di conversazione e lettura. Il vento degli imprevisti le spazza via. Quando indaghiamo sulla parola “lavoro” è bene sapere ciò che chiediamo. Il lavoro si rifiuta di seguire le tendenze storiche. Gli errori commessi dalle tendenze e dalle previsioni possono rilevarsi utili, indirizzandoci passo dopo passo verso la verità. Se saremo audaci nell’innovare, costruiremo un mondo migliore del lavoro che valorizzerà gli individui, oltre a produrre un dividendo di produttività.
La costruzione volontaria del lavoro di domani è un processo continuo, un esercizio che richiede determinazione, volontà di apprendere, visioni, immagini mentali di un insieme di convinzioni circa il lavoro. Tra queste, l’opportunità che offrono le donne al mondo del lavoro. Abili a lavorare in contemporanea su più progetti, le donne sono ben esposte all’ideazione. E di idee creative il lavoro ha tanto bisogno, a partire dalla riconoscibilità sociale del proprio ruolo e dalla riappropriazione del tempo di vita. Le persone non sono risorse. Le risorse si usano e si sfruttano, sono sostituibili come sta già accadendo con il ricorso all’intelligenza artificiale. Concentrandosi sulla triade risorsa-assunzione-intercambiabilità si trascurano il ben-essere dei dipendenti e le loro abilità ed esperienze irripetibili. Essere occupato come risorsa è, dunque, cosa ben diversa dall’essere una persona intenzionata a vivere in modo salutare e saggio, con la passione e la capacità di ideare. Il lavoro non è unicamente quantità che si misura, ma soprattutto qualità delle relazioni con la famiglia, gli amici e la comunità, irrinunciabili per il buon vivere. Le donne mostrano un’alta propensione a creare connessioni sociali e promuovere la cooperazione.
La società fondata sull’Umanesimo Economico non è un’utopia

È utopica la società fondata sull’Umanesimo Economico? No. Lo dimostrano i realisti dell’utopia con le loro idee seguite da passi pratici che centrano obiettivi significativi per il progresso verso un mondo migliore. Tra costoro spicca la figura di Robert Owen (1771-1858), produttore tessile gallese, che nei suoi stabilimenti di New Lanark, un villaggio di filatura di cotone in Scozia, mise in pratica idee utopistiche quali:
- Per i figli dei lavoratori, l’istruzione olistica (in linea con i princìpi odierni della transdisciplinarietà) che connette discipline le più varie, le materie accademiche con le attività pratiche, il gioco con l’esplorazione, e incoraggia il pensiero critico nell’apprendimento e la cooperazione.
- A confronto degli standard prevalenti, salari più alti, orari lavorativi ridotti (da diciassette a dieci ore) e ambienti di lavoro più puliti e sicuri.
- Alloggi dignitosi, assistenza sanitaria e strutture ricreative per i lavoratori e le loro famiglie, così promuovendo la costruzione di comunità.
Con la sua significativa impronta umanistica, il Nuovo Mondo morale di Owen è andato incontro a dure critiche che hanno portato molti a considerarlo irrealistico. I critici hanno attaccato la società armoniosa e cooperativa di Owen accusandola di essere altamente strutturata e, quindi, di sopprimere l’individualità e le libertà personali. Inoltre, essa omette il valore della diversità degli obiettivi, dell’ambizione e della competizione nelle interazioni umane. Infine, mortificare l’etica lavorativa che alza la produttività complessiva motivando gli individui ad eccellere – una motivazione che verrebbe a mancare qualora tutti ricevessero ciò di cui hanno bisogno indipendentemente dal loro impegno. Cosa ne è oggi dei benefici conclamati? In assenza di Umanesimo, l’individuo è uno sfrenato egoista; l’impennata delle disparità reddituali ha ridotto a molti l’esercizio delle libertà personali, soprattutto quelle all’accesso a un’istruzione di qualità e all’assistenza sanitaria indispensabile nella formazione del potenziale di una persona; la competizione è un serpente velenoso (vince chi morde, perde chi è morso), un gioco finito che non evolve spontaneamente verso la coopetizione in cui convivono tra le parti in campo comportamenti cooperativi e competitivi; l’impegno secondo il canone meritocratico risente della mancanza delle condizioni di parità dovute anche a distorte metriche del merito che, proprio per il deficit di Umanesimo, incorporano pregiudizi culturali, demografici, etnici, sociali e corporativi.

Il tempo trascorre, ma non si spezza il filo dell’Umanesimo Economico. Nel Novecento, ad afferrarlo è stato un altro eminente realista dell’utopia, Adriano Olivetti (1901-1960) che nel 1931 diventa amministratore delegato dell’impresa Ing. Camillo Olivetti & Company, fondata dal padre Camillo nel 1908. Sotto la guida di Adriano, Olivetti enfatizza l’Umanesimo Economico. Princìpi etici e sociali modellano un ambiente di lavoro che è un laboratorio di creatività e innovazioni tese al miglioramento dell’impresa e della società civile. Vi contribuiscono forti investimenti nella ricerca e sviluppo e nella formazione dei dipendenti, la loro partecipazione al processo decisionale, salari alti e orari di lavoro flessibili, e la presenza nello staff aziendale di intellettuali, tra i quali lo scrittore Paolo Volponi (1924-1994), che valorizzò la visione sociale e solidaristica dello sviluppo industriale. Con la rivista mensile Comunità, Olivetti apre il dialogo con il modo esterno all’impresa. Vi si dibattono la responsabilità sociale dell’attività d’impresa e l’innovazione urbanistica nel territorio di Ivrea quartier generale della Olivetti; si presentano articoli su un vasto panorama intellettuale che include letteratura, filosofia, arte e musica; si sollevano questioni sul progresso sociale, sui rapporti di lavoro e i bisogni umani.
Non meno di Owen, Adriano Olivetti ha subìto forti critiche. Gli azionisti temevano che un ampio ventaglio di benefici concessi ai lavoratori deprimesse i profitti e, conseguentemente e, i proventi dei titoli azionari. La massimizzazione dei profitti e dei dividendi non doveva essere messa in discussione. La ricerca di un sano e sostenibile equilibrio tra obiettivi economici e programmi sociali resta argomento di duri scontri. L’Umanesimo Economico continua a sbattere contro l’alto muro sollevato nel tempo dagli economisti che si concentrano esclusivamente sulla massimizzazione del profitto come leva della crescita economica. Tuttavia, chiuso l’Umanesimo in un recinto, è tutt’alto che scontata la quiete economica assicurata dalla corda del profitto tesa al massimo. Al contrario, si origina una condizione climatica che prelude alla tempesta.
La lezione di Owen, Olivetti e altri imprenditori realisti dell’utopia è che la crescita aziendale è il frutto dei tanti fattori che contraddistinguono l’Umanesimo Economico. L’economista e filosofo Amartya Sen ha dato particolare rilievo all’assistenza sanitaria, all’istruzione, al contrasto allo sfruttamento delle persone e alla disuguaglianza – fattori sui quali può molto incidere la filosofia aziendale che racchiude i princìpi fondamentali regolatori della vita dell’impresa. Sotto le ali dell’Umanesimo Economico, l’impresa è strumento del progresso sociale.
* Piero Formica, Professore di Economia della Conoscenza, è Thought Leader e Senior Research Fellow dell’Innovation Value Institute presso la Maynooth University (Irlanda) e professore presso il MOIM—Open Innovation Management, Università di Padova. Il professore ha vinto l’Innovation Luminary Award 2017, assegnato dall’Open Innovation Strategy and Policy Group sotto l’egida dell’Unione Europea “per il suo lavoro sulla moderna politica dell’innovazione”. Nel 2024 ha ricevuto il Premio Magister Peloritanus, rilasciato dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti, fondata dall’Università di Messina nel 1729, “per l’innovazione e l’imprenditorialità”. Questi i suoi libri più recenti: One Health: Transformative Enterprises, Wellbeing and Education in the Knowledge Economy (2023), Sciencepreneurship: Science, Entrepreneurship and Sustainable Economic Growth (2023), entrambi pubblicati da Emerald Publishing Group, e Intelligenza umana e intelligenza artificiale: Un’esposizione nella Galleria della Mente (2024), Edizioni Pendragon.